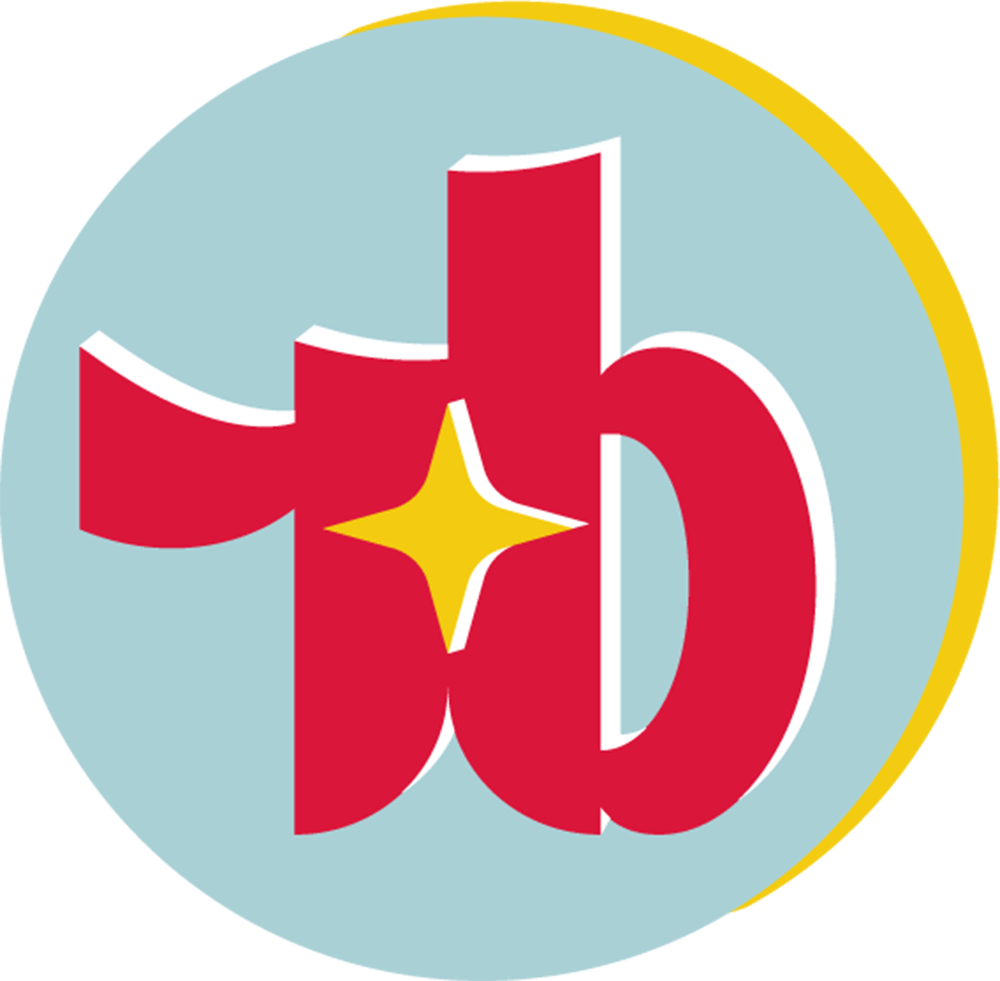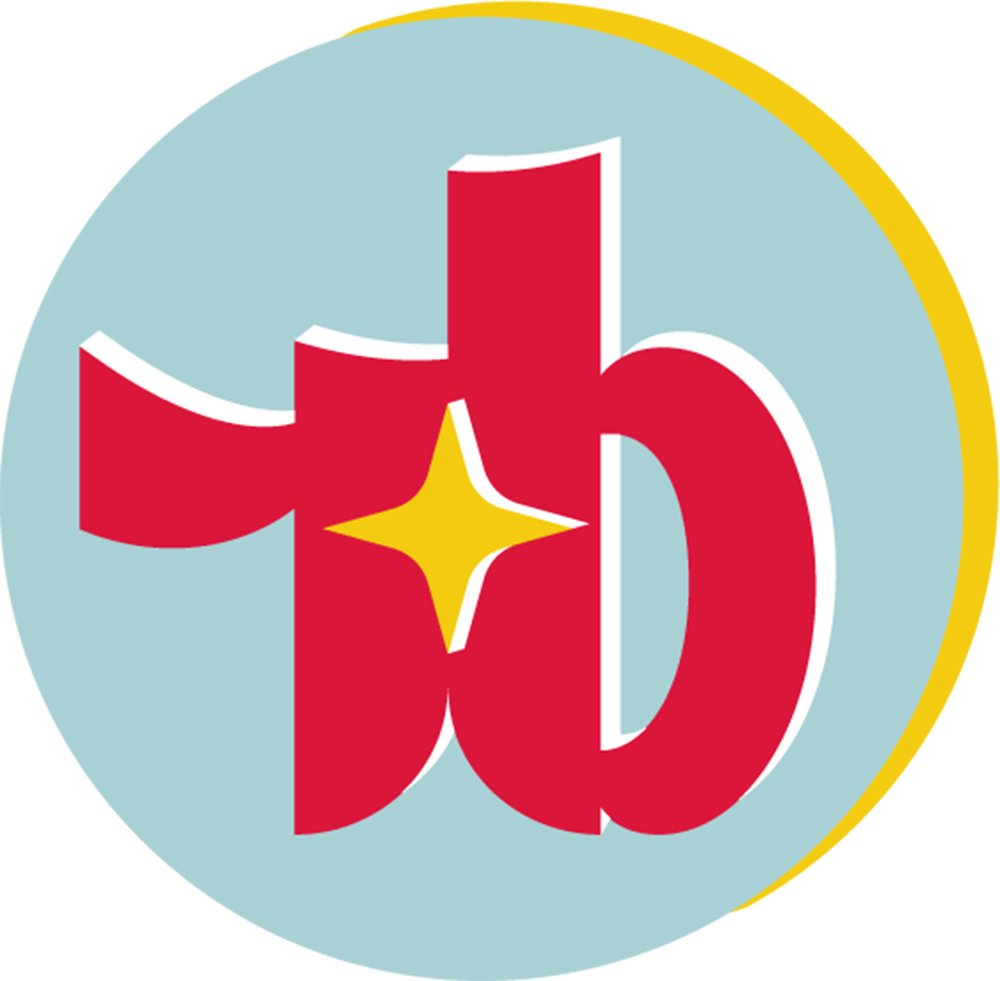Intervista esclusiva ad Aureliano Amadei
Ufficio stampa Studio PUNTOeVIRGOLA
www.rbcasting.com/site/aurelianoamadei.rb
 Trascorrere un’ora con Aureliano Amadei, regista e scrittore romano di 36 anni, è come rivedere “20 sigarette”, suo primo lungometraggio per il cinema. Aureliano è l’unico civile sopravvissuto alla strage di Nassirya, il film ne racconta i fatti così come lui li ha vissuti. Dalle parole che snocciola senza sosta per questa lunga intervista trasudano onestà e verità. E lo stesso vale per quella storia che ha voluto portare sugli schermi: “un aspetto del film di cui vado particolarmente orgoglioso è la non spettacolarizzazione della guerra – dice -. Ho cercato di raccontare una situazione squallida, senza ralenti o primi piani di facce terrorizzate e sofferenti, senza colpi ad effetto che dilaniano i corpi”.
Trascorrere un’ora con Aureliano Amadei, regista e scrittore romano di 36 anni, è come rivedere “20 sigarette”, suo primo lungometraggio per il cinema. Aureliano è l’unico civile sopravvissuto alla strage di Nassirya, il film ne racconta i fatti così come lui li ha vissuti. Dalle parole che snocciola senza sosta per questa lunga intervista trasudano onestà e verità. E lo stesso vale per quella storia che ha voluto portare sugli schermi: “un aspetto del film di cui vado particolarmente orgoglioso è la non spettacolarizzazione della guerra – dice -. Ho cercato di raccontare una situazione squallida, senza ralenti o primi piani di facce terrorizzate e sofferenti, senza colpi ad effetto che dilaniano i corpi”.
Prima della strage Amadei era un ragazzo di 28 anni, un documentarista che odiava le armi e sognava il cinema. Era partito per l’Iraq al seguito di Stefano Rolla, nemmeno il tempo di fumare 20 sigarette e tutto è saltato in aria. Di quella terribile esperienza che costò la vita a 19 persone, adesso porta i segni negativi (un piede che sta andando in necrosi, gli attacchi di panico), ma anche un paio di tracce positive: la svolta professionale e una visione diversa delle piccole “cose intime” della vita. “Dopo l’attentato mi è cambiato tutto un mondo – spiega – adesso credo negli esseri umani e nella loro individualità, non potrei più definirli per compartimenti stagni”.
Nato a Trastevere da genitori “hippies”, Aureliano mangia pane e pellicola sin da piccolo. Il merito è del nonno Gianni, “un grande lavoratore del cinema” che lo porta sul set dei fratelli Avati all’età di due anni. A cinque ottiene il primo ruolo da protagonista nel film “Progetti di Allegria” di Vittorio De Sisti, dopo il liceo va a Londra per frequentare l’Accademia d’Arte Drammatica “Webber Douglas” dove si diploma come attore. Tornato in Italia prende parte a varie pellicole tra cui “Il Talento di Mr Ripley” di Anthony Minghella, “I cavalieri che fecero l’impresa” e “La rivincita di Natale”, entrambi di Pupi Avati. Sul set dei fratelli cineasti inizia un percorso da regista scalando tutti gli step del mestiere: runner, macchinista, aiuto operatore, elettricista, segretario di produzione. Nel 2001 arriva il debutto alla regia teatrale con “Unamunda” di David Ives, seguito da una serie di documentari per la televisione, tra cui “Cercando Stella – La vita di Celeste di Porto” e “Non pensavo che la vita fosse così lunga – Biografia di Tiberio Mitri”.
Nel 2005 decide di raccontare l’attentato subito in Iraq in un libro che scrive con Francesco Trento, “Venti sigarette a Nassirya” (Einaudi). Tre anni dopo fonda una sua casa di produzione grazie alla quale comincia a produrre documentari suoi e di altri autori. Tratto dall’omonimo scritto, il film “20 sigarette” è stato presentato all’ultima Mostra di Venezia e quasi contemporaneamente è uscito nelle sale. Dopo aver vinto il premio della sezione Controcampo, il premio Pasinetti per il protagonista Vinicio Marchioni (nei panni del regista) e numerosi altri riconoscimenti, si è aggiudicato quattro David di Donatello. Miglior produttore (Tilde Corsi e Gianni Romoli), miglior montaggio (Alessio Doglione), migliori effetti speciali visivi (Rebel Alliance) e David Giovani.
 Che cosa si prova a vincere quattro David al primo lungometraggio?
Che cosa si prova a vincere quattro David al primo lungometraggio?
Emozioni enormi e indescrivibili. E’ un grande riconoscimento al film e soprattutto alle nuove leve che hanno partecipato. Ci tengo a sottolineare che tre dei candidati al David (le nomination erano otto, ndr) si affacciavano per la prima volta alla competizione per concorrere con dei veri mostri sacri del cinema italiano. Si dice sempre che bisogna dare spazio ai giovani ma non succede mai. Ecco, noi siamo passati dalla teoria alla pratica.
Dopo l’uscita nelle sale sei andato spesso nelle scuole a parlare della tua esperienza. Che cosa significa un David assegnato dai giovani in questo contesto?
E’ una conclusione gloriosa ma naturale: arriva alla fine di un percorso che ho ritenuto importante fin dall’inizio. Andare nelle scuole è un’esperienza fantastica che non mi stanco mai di ripetere. Con i ragazzi c’è un contatto diverso, sono capaci di “rimettersi in considerazione”. Il tema del film è proprio questo, riconsiderare le nostre vite e metterle in relazione con la guerra nel mondo. Ho anche una pagina su Facebook per i commenti: è emozionante sentire che il tuo cinema va oltre l’intrattenimento.
Che domande ti fanno di solito?
Mi chiedono consigli su come uscire dalla disinformazione. Dicono: se i giornali ci nascondono le notizie, i telegiornali ci raccontano stupidaggini e internet è pericoloso, noi che dovremmo fare? A questo tipo di domande non so dare una risposta…però il dibattito che viene fuori è interessante.
E riguardo alle armi?
Quando mi chiedono un’opinione sulle armi è chiaro che stanno valutando una carriera militare: le mie parole, allora, diventano una specie di missione. Da parte mia cerco di dimostrare che non ho pregiudizi: è una professione come le altre, solo è più evidente. Dico che siamo tutti carnefici e non vittime, perché i mandanti degli omicidi di guerra siamo noi, con i nostri stili di vita, i gadget, la smania di apparire. Insomma non ne faccio una questione morale però avverto: ricordiamoci che prima di essere impiegati, direttori di banca o giornalisti, siamo delle persone. E il mestiere delle armi ci mette in una situazione dove, prima di accorgerci chi siamo e se la scelta è giusta o sbagliata, rischiamo di essere già morti.
Il presidente Napolitano si è commosso, la critica ti ha ricoperto di applausi e premi. Eppure nelle sale non c’è stata l’affluenza sperata…
E’ un film dalla vita lunga. Dopo le otto settimane di programmazione, ho partecipato a tante matinée con 1.200 ragazzi, ci sono stati i cine-circoli e le rassegne. Detto questo, è chiaro che la distribuzione piccola (50 copie ridotte a 30 dopo i primi tre giorni), l’estate lunga e la fame per le commedie hanno determinato un botteghino non entusiasmante.
Tg e talk show trasmessi a ridosso dell’attentato hanno avuto un’audience altissima. Come te lo spieghi? Colpa del pubblico che dimentica tutto?
Non è il pubblico che dobbiamo criticare ma l’intero sistema cinema italiano. Non conviene a nessuno continuare a spingere l’acceleratore su film che incassano milioni di euro e poi spariscono dal panorama mondiale. Dovremmo invece investire su prodotti che abbiano una vita più lunga: non per girare film introspettivi e difficili che nessuno va a vedere, ma per fare soldi con pellicole illuminate. Abbiamo tutti applaudito “Benvenuti al Sud” che in Italia ha incassato quasi 30 milioni di euro, ma non ci siamo resi conto che l’originale francese, “Giù al Nord”, solo in Francia ha incassato 140 milioni di euro. Insomma, gioiamo per risultati sorprendenti che però non sono paragonabili ai nostri fenomeni del passato (le commedie di Monicelli vendevano in 60-70 paesi) o a certi film europei.
E’ chiaro che non è la guerra che interessa, ma lo spettacolo della guerra.
Non credo che gli ascolti registrati a ridosso dell’attentato provengano da una reale necessità del pubblico. Ci sono cose che, pur essendo imposte, alzano automaticamente la curva dell’auditel. L’attentato a Nassirya è solo uno dei tanti casi di cronaca. Purtroppo oggi la tv ha il potere di esercitare una grande violenza nei confronti dello spettatore.
Quindi?
Un aspetto del film di cui sono particolarmente orgoglioso è proprio la “non spettacolarizzazione” della guerra. Ho cercato di raccontare una situazione squallida, senza ralenti o primi piani di facce terrorizzate e sofferenti, senza i colpi ad effetto che dilaniano i corpi. Si tratta di un elemento nuovo: avendo vissuto l’esperienza, credo di avere qualcosa da insegnare a Kathryn Bigelow o ai maestri del genere. Insomma, se l’obiettivo del film è un messaggio di pace, la fascinazione per la guerra va evitata. E’ un dato di fatto che vedendo “Full Metal Jacket” di Stanley Kubrick molti ragazzi americani hanno scelto di arruolarsi.
In “20 sigarette” c’è una giovane soldatessa che va via delusa dalla stanza d’ospedale del protagonista quando si accorge di essersi imbattuta nell’unico civile sopravvissuto. Un fatto vero o un’invenzione?
E’ un fatto verissimo, tutti gli avvenimenti del film sono accaduti davvero. Alcuni nodi narrativi sono stati semplificati, ma nulla è stato aggiunto.
La ricostruzione dell’attentato è tutta girata in soggettiva. Una scelta immediata?
Sì, ci ho pensato subito. L’elaborazione tecnica è stata piuttosto complicata, ma era l’unico modo per raccontare l’accaduto in maniera onesta. Un punto di vista diverso dal mio avrebbe comportato un’invenzione, una ricostruzione artificiosa che per motivi etici non mi sentivo di fare.
Perché hai scelto di partire dalle sigarette?
Perché caratterizzano immediatamente il personaggio, che non si pone come un esperto di geopolitica o come un inviato di guerra. Al contrario affronta la storia dal basso, con lo sguardo un po’ ingenuo e spaesato di chi ha avuto appena il tempo di fumarsi 20 sigarette.
Che mi dici della polemica con il Ministero della Difesa?
A Venezia volevo parlare dei familiari delle vittime e non fare polemica. Un personaggio vicino alla Difesa aveva mandato una mail ad alcuni di loro chiedendo di protestare per bloccare il film, i familiari avevano risposto che non avrebbero espresso giudizi a priori. Dopo aver visto la pellicola, non solo queste persone non l’hanno bloccata, ma mi hanno chiamato per ringraziarmi di aver raccontato i fatti con onestà.
Nel film, quando i genitori di una delle vittime, il Tenente Massimo Ficuciello, ti vengono a trovare in ospedale, c’è un grande momento di commozione.
Con loro ci vediamo ancora regolarmente. Erano a Venezia: in sala grande ci siamo abbracciati e abbiamo pianto. Nella pellicola ho cercato di esprimere tutta la mia stima per Massimo e credo di esserci riuscito.
Quanto è stato difficile rielaborare l’esperienza?
Soprattutto è stato difficile staccarsi dalla persona Aureliano. Nel raccontare la propria vita si tende a essere meticolosi su alcuni dettagli che ai nostri occhi sembrano essenziali, mentre per gli altri sono superflui. Consideriamo che, rispetto all’esperienza, il film è un distillato. Faccio un esempio: la mia storia non ha un finale perché io sono qui a parlare e domani farò altro, ma il film deve avere un finale. Prima di trovarne uno vero, credibile e allegorico ci sono voluti anni di riflessione.
 Che rapporto hai avuto con Marchioni?
Che rapporto hai avuto con Marchioni?
Sicuramente un rapporto di simbiosi: per preparare il film abbiamo convissuto qualche mese sviluppando un legame profondo, nel frattempo abbiamo portato avanti un percorso artistico che stimolasse i nostri interessi. Ne è venuta fuori una collaborazione implicita sul set, dove non c’era quasi bisogno di parlare. I risultati sono legati anche allo stesso Vinicio, un vero lavoratore del cinema che non aspetta che l’ispirazione gli piova addosso.
Come l’hai scelto?
Con una selezione piuttosto faticosa, soprattutto per lui. Inizialmente è stato scelto per il ruolo di Chico, l’amico del centro sociale, tre scene in tutto. Ma il film è slittato all’anno successivo e, nella nuova sessione di casting, l’abbiamo rivisto per la parte di Ficuciello. Quando abbiamo fatto la stretta finale sul protagonista ci siamo resi conto che Vinicio era l’attore giusto. L’abbiamo poi sottoposto a una serie di prove e lui ha resistito a tutto.
Com’è cambiata la tua vita professionale dopo l’attentato?
In quel momento mi trovavo a un bivio tra recitazione e regia. Il mio percorso professionale parte dalla regia, un settore in cui ho fatto un lungo apprendistato, mentre a fare l’attore sono finito per caso. Dopo l’attentato la scelta è stata obbligata.
E la visione della vita?
A livello macroscopico non è cambiata di una virgola: non c’è stata una conversione spirituale, ideologica o politica. Dal punto di vista della sensibilità personale, invece, è cambiato tutto un mondo. Innanzitutto perché quel giorno è finita la mia adolescenza: ho perso quel senso di invincibilità che avevo, ma sono arrivati gli attacchi di panico e la difficoltà ad accettare la precarietà economica e affettiva. Adesso credo agli esseri umani e alla loro individualità. Non potrei più metterli nei contenitori che li definiscono per il ruolo che ricoprono.
Che cosa ha rappresentato questo film per te?
Una grande apertura di prospettive ma anche un grande vincolo. Se vado a rispolverare le storie che volevo raccontare prima le trovo tutte inadeguate, adesso c’è una certa aspettativa nei miei confronti. Riguardo alla passione e alla voglia di fare non è cambiato nulla: proprio in questi giorni ho ripreso a girare documentari.
Che cosa stai girando in questo momento?
Un documentario sul crack finanziario della Metro Goldwyn Mayer che abbraccia la storia, l’economia, il cinema e la biografia. Il tracollo della MGM contiene un ritratto avvincente, quello del suo protagonista Giancarlo Parretti: un uomo che, partendo dal niente, ha saputo costruirsi una carriera incredibile.
Prima di “20 sigarette” hai anche raccontato la vita di Tiberio Mitri.
Un libro che ho scritto con Alessandro Falcone e Gian Piero Palombini, e che poi è diventato un documentario. Anche lì ho messo insieme varie componenti: la biografia del pugile, la carriera cinematografica, la storia dei nostri costumi. In fondo è lo stesso percorso del film e del documentario sulla MGM: si parte da piccole storie per raccontare la storia con la S maiuscola.
Che ricordi hai dell’esperienza con i fratelli Avati?
A loro sarò sempre e infinitamente grato. Mi hanno insegnato il set, che per un regista è una buona metà della tecnica. Si scrivono sempre grandi trattati sul linguaggio e ci si concentra poco su una caratteristica fondamentale, la capacità di gestire il set. Ecco, se sono riuscito a girare il mio film in sei settimane e quattro ore di straordinari lo devo anche a Pupi e Antonio.
A parte loro, chi sono stati i tuoi maestri?
All’Accademia di Londra ho avuto la fortuna di studiare con insegnanti molto prestigiosi come Edward Clark e Stewart Pearce. In più sono un appassionato di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, mentre “Babel” di Alejandro Gonzalez Inarritu è uno dei film mi hanno scioccato di più. Infine sono un amante di tutte le pellicole di Paolo Virzì, tranne l’ultima.
Che regista è Aureliano Amadei?
Mi piacerebbe potermi definire un regista “pericoloso”.
Se non avessi fatto questo lavoro?
Mi piacciono tutti i lavori manuali: il fabbro, lo skipper, il coltivatore diretto, il muratore, il falegname.
Dopo l’attentato è arrivata anche la famiglia.
Aureliano, Claudia, Flavia e Tito. Claudia è la ragazza del film (interpretata da Carolina Crescentini, ndr), Flavia ha quattro anni e mezzo, Tito uno e mezzo.
Che papà sei?
Molto assente purtroppo (sospira). Dopo questi mesi deliranti, è la prima cosa che mi viene in mente e che mi preme di più. Per il resto spero di essere un papà libertario.
Un po’ come i tuoi genitori…
Da piccolo mi lasciavano spesso in comune per i loro viaggi.
Quanto ha influito la loro filosofia di vita sul tuo modo di essere oggi?
Sicuramente parecchio. Ho sempre avuto la sensazione di essere diverso dagli altri, già dal nome. Mi piacerebbe dire che viene dall’Imperatore Aureliano, ma in realtà è ispirato al personaggio di Aureliano Buendìa di “Cent’anni di solitudine”…roba per fricchettoni. Tutto, anche il fatto che andavo poco a scuola per visitare l’India o il Nepal, mi faceva sentire unico. La scena in bicicletta del film (il protagonista gira per Roma con le cuffie da stereo senza curarsi delle auto e dei semafori, ndr) ha fatto parte della mia vita per tanto tempo. Mi chiamavano “u pazz ‘a pedal”.
Nel film c’è la “diversità” ma anche l’amore. Soprattutto nella scena in cui i tuoi ti ritrovano vivo in ospedale e Marchioni dice: “sembriamo un Presepe”…
La battuta è frutto di una grande improvvisazione di Vinicio. L’abbiamo girata in un solo ciak, per niente al mondo ci avrei rinunciato.
Un tuo difetto e un tuo pregio.
Sono un egocentrico e sono un iper comprensivo, nel senso che cerco di capire le ragioni di tutti.
Il vizio di cui non puoi fare a meno?
L’autolesionismo. Quando torno a casa e non ho una canna mi attacco alla boccia di whiskey, e se non ho nemmeno quella mi dò una bastonata in testa.
Il tuo sogno?
Vorrei riuscire a capirmi con le persone sempre e comunque, come le formiche con le antenne. Vorrei parlare con tre lingue tutti i dialetti del mondo.
La tua paura più grande?
Dare la vita per qualcosa che non capisco. Quando vedo una persona onesta che si costruisce una carriera e poi va serenamente in pensione, la ritengo una vittima. Lo stesso vale per un ragazzo che muore in guerra, o per il cinema che è la mia passione. La mia paura più grande è dedicare tutta la vita a un qualcosa e poi rendermi conto che non ne valeva la pena.