Intervista esclusiva a Daniele Gaglianone
Ufficio stampa Studio PUNTOeVIRGOLA
www.rbcasting.com/site/danielegaglianone.rb
 Quando gira un film non pensa al pubblico che lo vedrà o agli incassi del botteghino, ma allo spettatore come “entità percettiva e creativa”. “Qualcuno dice che pretendo troppo – spiega – ma io tratto lo spettatore da persona intelligente e matura, e mi aspetto di comunicare con lui”. Le sue storie parlano di quegli ultimi di cui nessuno vuole più occuparsi, gente che vive ai margini della società, segnata dalla violenza della vita e incapace di sottrarsi a un destino di vuoto esistenziale, prima ancora che di degrado economico e sociale. I temi più ricorrenti sono appunto la violenza, il Potere “grottesco e crudele”, il Male nelle forme più abiette. I luoghi quelli dov’è cresciuto: i quartieri periferici della Torino postindustriale, con i suoi palazzi sventrati e i cantieri sempre aperti. Lo stile, invece, è scomposto e frenetico, con i fatti che si sviluppano su molteplici piani narrativi, quasi a seguire il travaglio interiore dei personaggi.
Quando gira un film non pensa al pubblico che lo vedrà o agli incassi del botteghino, ma allo spettatore come “entità percettiva e creativa”. “Qualcuno dice che pretendo troppo – spiega – ma io tratto lo spettatore da persona intelligente e matura, e mi aspetto di comunicare con lui”. Le sue storie parlano di quegli ultimi di cui nessuno vuole più occuparsi, gente che vive ai margini della società, segnata dalla violenza della vita e incapace di sottrarsi a un destino di vuoto esistenziale, prima ancora che di degrado economico e sociale. I temi più ricorrenti sono appunto la violenza, il Potere “grottesco e crudele”, il Male nelle forme più abiette. I luoghi quelli dov’è cresciuto: i quartieri periferici della Torino postindustriale, con i suoi palazzi sventrati e i cantieri sempre aperti. Lo stile, invece, è scomposto e frenetico, con i fatti che si sviluppano su molteplici piani narrativi, quasi a seguire il travaglio interiore dei personaggi.
Daniele Gaglianone, 45 anni, torinese di mamma marchigiana e papà calabrese, è un regista conosciuto per i tanti documentari impegnati, molti dei quali passati al Torino Film Festival, e per i quattro lungometraggi di finzione: “I nostri anni” sui protagonisti della Resistenza, “Nemmeno il destino” e “Pietro”, sul dramma degli adolescenti ai margini, e “Ruggine”, favola nera di tre ragazzini alle prese con un orco violentatore. Tutti titoli realizzati con il produttore “autonomo” Gianluca Arcopinto che lo ha scoperto, e due dei quali co-prodotti dalla Fandango di Domenico Procacci. Come tutti gli autori Indie, Gaglianone non è fatto per il pubblico del cinepanettone, ma per chi ama un certo tipo di cinema: più duro e terribile, ma anche più vero.
 Con lui la critica si è spesso divisa, a volte maltrattandolo con recensioni fulminanti, altre volte riempiendolo di riconoscimenti. Tra gli altri è stato selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, ha vinto il Jerusalem Film Festival e la Sacher d’oro (“I nostri anni”), il Tiger Award all’International Film Festival di Rotterdam (“Nemmeno il destino”), il David di Donatello per il miglior documentario (“Rata Nece Biti”), ha concorso al Festival di Locarno e ricevuto una candidatura ai Nastri d’Argento (“Pietro”). Con il recente “Ruggine”, protagonisti Stefano Accorsi, Valeria Solarino, Valerio Mastandrea e Filippo Timi, Gaglianone ha aperto le Giornate degli Autori alla 68ma Mostra di Venezia.
Con lui la critica si è spesso divisa, a volte maltrattandolo con recensioni fulminanti, altre volte riempiendolo di riconoscimenti. Tra gli altri è stato selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, ha vinto il Jerusalem Film Festival e la Sacher d’oro (“I nostri anni”), il Tiger Award all’International Film Festival di Rotterdam (“Nemmeno il destino”), il David di Donatello per il miglior documentario (“Rata Nece Biti”), ha concorso al Festival di Locarno e ricevuto una candidatura ai Nastri d’Argento (“Pietro”). Con il recente “Ruggine”, protagonisti Stefano Accorsi, Valeria Solarino, Valerio Mastandrea e Filippo Timi, Gaglianone ha aperto le Giornate degli Autori alla 68ma Mostra di Venezia.
Tra un impegno e l’altro (è già al lavoro su due nuove sceneggiature), gli chiediamo di raccontarsi. E’ nella casa torinese con i suoi bambini – Tommaso di 6 anni e Tobia di 2 e mezzo – che per tutta l’intervista reclamano attenzioni, cercando con ogni mezzo di allontanarlo dal telefono. Lui, con dolcezza, li accontenta e poi torna, li accontenta di nuovo e poi ritorna, senza perdere di vista né i loro capricci né il filo del discorso. E parla di tutto: dal rapporto con la prima persona che ha creduto in lui ai giudizi della critica più ostile, dall’umanità degli ex partigiani – conosciuti con l’ANCR (Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza) – agli esordi con Gianni Amelio. E poi Berlusconi, Monti, l’infanzia tra gli immigrati meridionali della Torino anni ’70 e soprattutto la passione per il cinema, nata a 15 anni.
 Gaglianone, mi racconta i primi innamoramenti per il cinema?
Gaglianone, mi racconta i primi innamoramenti per il cinema?
Sono nati con i film che vedevo in tv e al cinema, e grazie alle mie sorelle più grandi, che mi portavano in un Cineclub. Allora puntavo su generi piuttosto eterogenei, nel senso che alcuni titoli li apprezzo ancora e altri meno. Impazzivo per Alan Parker, credo di aver visto “Birdy” almeno cinque volte. Adesso le sue pellicole mi piacciono comunque, ma riconosco che non hanno grandi pretese.
I registi che segue tuttora?
Credo che l’interesse per il cinema sia nato quando si faceva una televisione di tutto rispetto. Ricordo una retrospettiva su Peter Watkins, il cui film più famoso è un falso documentario su un’esplosione atomica in Inghilterra (“War Game”, 1965). Ecco lui è un autore che mi aveva colpito molto e ancora seguo.
Chi sono i suoi maestri?
E’ una definizione onnicomprensiva e allo stesso tempo limitante, perché ci sono autori che mi piacciono molto ma rispetto ai miei film non hanno un’influenza visibile o proprio non ce l’hanno. Però posso fare una serie di nomi: John Ford, Andrej Tarkovskij, Jean Vigo, Werner Herzog, e gli italiani Vittorio De Sica, Roberto Rossellini e Gianni Amelio.
E’ vero che voleva fare l’informatico?
Dopo il diploma in ragioneria mi sono iscritto a un corso di informatica. Un anno buttato via ma molto importante, perché mi ha fatto capire che volevo seguire un’altra strada e che il cinema non lo guardavo da semplice spettatore.
Che cosa l’ha convinta a cambiare idea?
Mi mancava qualcosa, anche se non sapevo bene di cosa si trattasse. Sapevo solo che dovevo farla perché dopo sarei stato meglio. Così ho lasciato l’informatica e mi sono iscritto alla Facoltà di Lettere Moderne a Torino, dove ho seguito il corso di storia e critica del cinema di Gianni Rondolino. Un corso per me fondamentale, perché mi ha permesso di vedere film che da autodidatta non avrei mai visto: l’espressionismo tedesco, il cinema muto, le avanguardie storiche.
Dopo l’Università?
Nel ’90 ho cominciato a collaborare con l’ANCR di Torino, cinque anni importanti durante i quali ho incontrato un mondo straordinario. Oltre al lavoro di archiviazione dei vecchi documentari, facevamo delle vere e proprie campagne di raccolta di testimonianze orali, incontrando i protagonisti della guerra partigiana. Se non avessi vissuto quell’esperienza il film “I nostri anni”, che ho girato nel 2000, non l’avrei neanche pensato.
Cosa l’ha colpita di più degli ex partigiani?
Il fatto che la Resistenza sia sconosciuta ai più. Ero un operatore video e non conducevo le interviste, ma ascoltando queste storie mi rendevo conto di quanta ricchezza umana e politica contenessero. Una ricchezza che, anche negli esempi migliori, è stata sempre riportata parzialmente. E mi ha colpito il fatto che questi personaggi mi vedevano come un ragazzino, ma io avevo 27 anni e di età ero molto più grande di loro giovani partigiani. In fondo mi raccontavano storie di ragazzi dai 17 ai 19 anni, e se ne avevano 23 erano già considerati dei vecchi. Siamo abituati a pensare alla Resistenza come a una storia di vecchi quando in realtà si tratta di giovanissimi.
 La prima esperienza cinematografica è sul set di Amelio. Come vi siete incontrati?
La prima esperienza cinematografica è sul set di Amelio. Come vi siete incontrati?
Ci siamo conosciuti nel ’95. Lui aveva visto dei miei cortometraggi, in particolare “L’orecchio ferito del piccolo comandante”, ambientato in guerra. Mi chiamò due anni dopo: voleva girare “Così ridevano” (poi Leone d’Oro a Venezia 55, ndr) a Torino e aveva bisogno di una persona fidata che conoscesse bene la città. Iniziò così una collaborazione a 360 gradi: ai tempi la Film Commission era ancora allo stato primordiale e io feci un po’ da jolly per la ricerca di location e comparse, oltre a collaborare alla riscrittura della sceneggiatura durante le riprese. Fu una grande esperienza formativa, anche perché sul set c’erano grandi nomi. Da Giancarlo Basili per la scenografia a Luca Bigazzi per la fotografia, fino a Mario Cotone come organizzatore.
Il suo primo lungometraggio è stato possibile anche grazie ad Arcopinto, che nel Benvenuto di RB Casting ha parlato molto di lei. E’ vero che all’inizio l’ha rincorso?
Si, è vero (ride). E’ stato un inizio strano…Gianluca è uno dei pochi produttori che segue da sempre il Torino Film Festival, dove aveva visto i miei corti e i miei documentari. Gli diedi la sceneggiatura de “I nostri anni” nel ’95 e poi non ne seppi più niente. Qualche anno più tardi, un amico in comune ci fece incontrare di nuovo e io ne approfittai per ridargliela. Mi chiamò dopo una settimana (devo ammettere che non me l’aspettavo!), gli era piaciuta e voleva fare il film.
Arcopinto ha raccontato di una produzione difficile.
In realtà non me ne sono accorto: il budget non era ricco ma io non ne ho sentito la mancanza. Certo sapevo che non avevamo appoggi, né dalla Rai e tantomeno dal Ministero, e che nel rispondere alle nostre richieste qualcuno ha avuto dei modi un po’ maleducati…
Eppure è un film sulla Resistenza.
Forse è proprio questo il motivo di tanti rifiuti. La sceneggiatura ha una radicalità piuttosto forte: è la storia di due settantenni che in modo non eroico, anzi tenero e maldestro, decidono di dare la caccia a un fascista per pareggiare i conti. Nonostante l’età e le loro azioni per lo più contraddittorie, non si arrendono e hanno ancora voglia di dire no.
Una storia vera?
E’ una storia ispirata a storie che mi hanno raccontato. In fase di scrittura e durante le riprese non avevo mai saputo di ex partigiani che avessero compiuto un atto del genere. In seguito sono venuto a conoscenza di memoriali che parlavano di almeno due casi simili. Si può dire che l’humus del film è autentico.
 Che cosa significa fare cinema indipendente?
Che cosa significa fare cinema indipendente?
Ho un rapporto pragmatico e un po’ naïf con i miei lavori: non mi interessa appartenere a un genere o a un filone, ma è chiaro che fare film vuol dire anche fare un discorso sul cinema. E se per indipendente si intende un’attitudine a considerare la storia che voglio mettere in scena, il modo e lo spirito con cui la racconto, allora sono indipendente sempre. In alcune occasioni, però, il termine “indipendente” mi va un po’ stretto. Parlo di “Pietro”, come dice Arcopinto un vero esempio di cinema “autonomo”. A parte il contributo della Film Commission Torino Piemonte, la pellicola è stata prodotta con il nostro lavoro: per intenderci, io stesso non ho percepito compensi e lo stesso vale per diversi collaboratori e attori, ma tutti abbiamo una quota del film.
Essere autonomi vuol dire affrancarsi dalle eventuali imposizioni di un produttore o anche dal giudizio del pubblico?
Autonomia non vuol dire chiusura! Con Arcopinto, ma anche con Procacci, c’è sempre stato un confronto. Riguardo al rapporto con il pubblico nessuno ha in tasca la formula che piace, a meno che non si tratti di un cinepanettone. Non so esattamente cosa sia il pubblico e diffido di quelle persone che pretendono di saperlo, quando lavoro non penso al pubblico ma allo spettatore come entità percettiva e creativa. Qualcuno dice che pretendo molto e però potrei anche ribaltare la questione: io tratto lo spettatore da persona intelligente, matura, e mi aspetto di comunicare con lui. Quando faccio un film non perdo mai di vista chi lo guarderà ma non mi chiedo se e quanto incasserà: spesso si realizzano pellicole che incassano molto meno di quanto previsto e poi ci sono le sorprese, che magari non hanno le caratteristiche per piacere e però funzionano.
Nel suo secondo film, “Nemmeno il destino”, cambia completamente tema per raccontare il dramma di tre ragazzi ai margini. L’amicizia nonostante tutto, il vuoto esistenziale, il degrado sociale e affettivo, sono concetti che appartengono a questa storia ma anche alle storie che verranno.
Il mio interesse è sempre rivolto alle situazioni estreme, quando le persone si trovano di fronte a un limite sociale, esistenziale o anagrafico. “Nemmeno il destino” è nato dall’incontro con il libro omonimo di Gianfranco Bettin, una storia che mi ha subito impressionato perché ci ho rivisto alcuni aspetti della mia adolescenza. Il film mi ha dato molte soddisfazioni e ancora adesso, soprattutto quando viene proiettato all’estero, continua a colpire. Quando è uscito nelle sale, però, è stato capito poco. A leggere la recensione del Mereghetti e la motivazione del Tiger Award assegnato dal Festival di Rotterdam del 2005, per esempio, l’impressione è che si sta parlando di due film diversi. A Torino qualcuno ha detto che il mondo delle fabbriche non era più così, io penso che forse la pellicola guardava con sensibilità eccessiva ciò che c’era intorno.
Anticipava i tempi?
Credo di sì. E lo dico con amarezza. Con soddisfazione dal punto di vista del regista, ma con amarezza dal punto di vista del cittadino. Lo stesso sta accadendo con “Pietro”, che diventa sempre più attuale.
 Entrambi i film sono ambientati nei quartieri periferici di Torino. Motivi autobiografici?
Entrambi i film sono ambientati nei quartieri periferici di Torino. Motivi autobiografici?
Sono nato ad Ancona e quando avevo 5 anni mi sono trasferito a Torino con la famiglia. Come tutti i torinesi della mia generazione, non sono di Torino e la periferia, come spazio fisico, sociale ed esistenziale, mi fa sentire a casa. Per i miei film scelgo sempre luoghi con una forte socialità, dal bosco di betulle de “I nostri anni” agli edifici di periferia di “Ruggine”, ma non dico mai esplicitamente dove siamo. In “Nemmeno il destino”, per esempio, non c’è nessuna inquadratura che fa pensare a Torino e però, appena si sente lo slang dei ragazzi, un misto di dialetti meridionali e vocali larghe (come parlo io insomma!), si capisce dove ci troviamo. Le mie storie, insomma, non vogliono raccontare un luogo preciso ma lasciano spazio a più punti di vista.
Anche “Pietro” viene dal suo vissuto?
In parte sì. Per il fatto che la figura del protagonista è ispirata a una persona che ho conosciuto nel passato, ma soprattutto perché è un film pensato in un momento di grande rabbia. La storia è nata appunto da un personaggio reale, un ragazzo all’apparenza debole e rassegnato che però nasconde una carica esplosiva e quasi inconsapevole. E’ l’immagine della solitudine che sempre di più pervade la nostra società, una sorta di energia che non riesce a trovare un punto di contatto e dunque ci condanna a girare a vuoto. Il film mostra come la violenza subita quotidianamente, anche nelle cose più spicciole, lascia sempre un segno, mentre le persone fragili sono quelle che in maggior misura possono restituire la violenza.
Sembra che la violenza sia un altro dei suoi argomenti preferiti…
E’ un tema ricorrente in tutti i miei film. La domanda è una: cosa fai quando la violenza viene a bussare alla tua porta? Chi diventi? Come reagisci? C’è molta ipocrisia a riguardo, nel senso che se ne parla pochissimo e viene fuori solo quando esplode.
 In “Ruggine” c’è la violenza e c’è l’analisi del Potere.
In “Ruggine” c’è la violenza e c’è l’analisi del Potere.
Anche questo film non è stato capito fino in fondo. Sostanzialmente perché è una fiaba disorientante, che non ha nulla di fiabesco. Come le favole che ascolti da bambino e rileggi da adulto: ne cogli il significato più profondo ma ti accorgi che molte di esse sono terribili. Ecco, “Ruggine” è una fiaba vissuta a metà, tra i personaggi bambini e gli stessi personaggi trent’anni dopo. Ma è anche una fiaba molto dura, un’allegoria del Potere, l’orco mascherato da persona rispettabile, e di come ci relazioniamo con il Potere. In questa storia solo i bambini, con la loro ingenuità, riescono a riconoscerlo per quello che è: grottesco e crudele. Il tema fondamentale è comunque quello della violenza, del confronto con il Male assoluto che vince sempre, anche quando lo sconfiggi. Perché cambierà per sempre il corso delle cose.
Si è parlato di come le persone fragili reagiscano alla violenza. Lei si sente più fragile o più forte?
Mi sento…mi sento fragile, perché capisco di essere in balìa di forze che non posso controllare. In questo periodo e nonostante tutti gli sforzi che facciamo, la nostra vita è sottomessa a un potere. Mi sento fragile perché avverto la fragilità del mondo che mi circonda, lo scricchiolio del ghiaccio su cui stiamo pattinando da anni. Perché c’è la precarietà economica, ma c’è soprattutto la precarietà filosofica, culturale ed esistenziale. Insomma ad essere precari sono prima di tutto i rapporti umani.
 Che cosa pensa di quel che è successo in Italia nelle ultime due settimane? E’ contento delle dimissioni di Berlusconi?
Che cosa pensa di quel che è successo in Italia nelle ultime due settimane? E’ contento delle dimissioni di Berlusconi?
Come faccio a non essere contento? E’ dal ’94 che, come cittadino, mi sento sistematicamente insultato. E però la soddisfazione di vederlo uscire con la coda fra le gambe e sbeffeggiato dalla comunità internazionale non toglie l’amarezza del disastro in cui siamo precipitati. La situazione è triste e i danni prodotti in questi ultimi trent’anni – quindi non solo da lui e dai suoi governi – sono davvero enormi.
Ha fiducia nel Governo Monti?
Siamo arrivati a un livello tale che basta essere una persona educata per riscuotere fiducia. Se guardo agli ambienti di riferimento e alla biografia del professor Monti non mi sento a mio agio. Ma dopo diciassette anni di nani e ballerine…
Con chi si sentirebbe a suo agio?
In questo momento né con partiti né con uomini politici, ce n’è qualcuno che stimo ma senza passione. Mi sembrano importanti alcuni movimenti dal basso come quelli che hanno portato alla vittoria dei referendum. Vent’anni fa a tirare le monetine a Craxi ci sarei andato, forse anche perché avevo vent’anni di meno. Dopo Craxi c’è stata la breve parentesi con Ciampi, e poi ci siamo tenuti Berlusconi per diciassette anni che dettava l’ordine del giorno anche quando non era al governo. Monti non mi spaventa ma quello che quei milioni di italiani – gli stessi che hanno sostenuto Berlusconi – saranno pronti a votare dopo…beh, quello mi spaventa molto.
 Torniamo ai suoi film. Non ha mai pensato a una commedia, o comunque a una storia meno cupa?
Torniamo ai suoi film. Non ha mai pensato a una commedia, o comunque a una storia meno cupa?
Trovo molto cupe delle storie che apparentemente non lo sono. Per me “Pietro” non è una storia cupa, ma un grande film di liberazione. Per quanto riguarda la commedia, c’è qualche idea nell’aria e ogni tanto ne parlo con un paio di miei amici autori. Prima o poi decideremo di fare qualcosa.
Adesso sta lavorando a qualche film?
Sto lavorando alla sceneggiatura di due esordienti, Davide Zurolo e Alessandro Legnazzi.
Che regista è Daniele Gaglianone?
Due parole chiave per descrivermi, rabbia e tenerezza.
Se non avesse fatto questo lavoro?
Sarei finito male…forse come uno dei miei personaggi.
E’ un papà apprensivo?
Cerco di essere presente senza invadere troppo i loro spazi, sono un po’ apprensivo ma anche un po’ complice. In qualche modo provo a capire e non solo a reagire.
Il vizio di cui non può fare a meno?
Mi piace perdere tempo a pensare.
Il suo sogno?
Non deludere i miei figli.
La paura più grande?
Non riuscire a proteggerli.
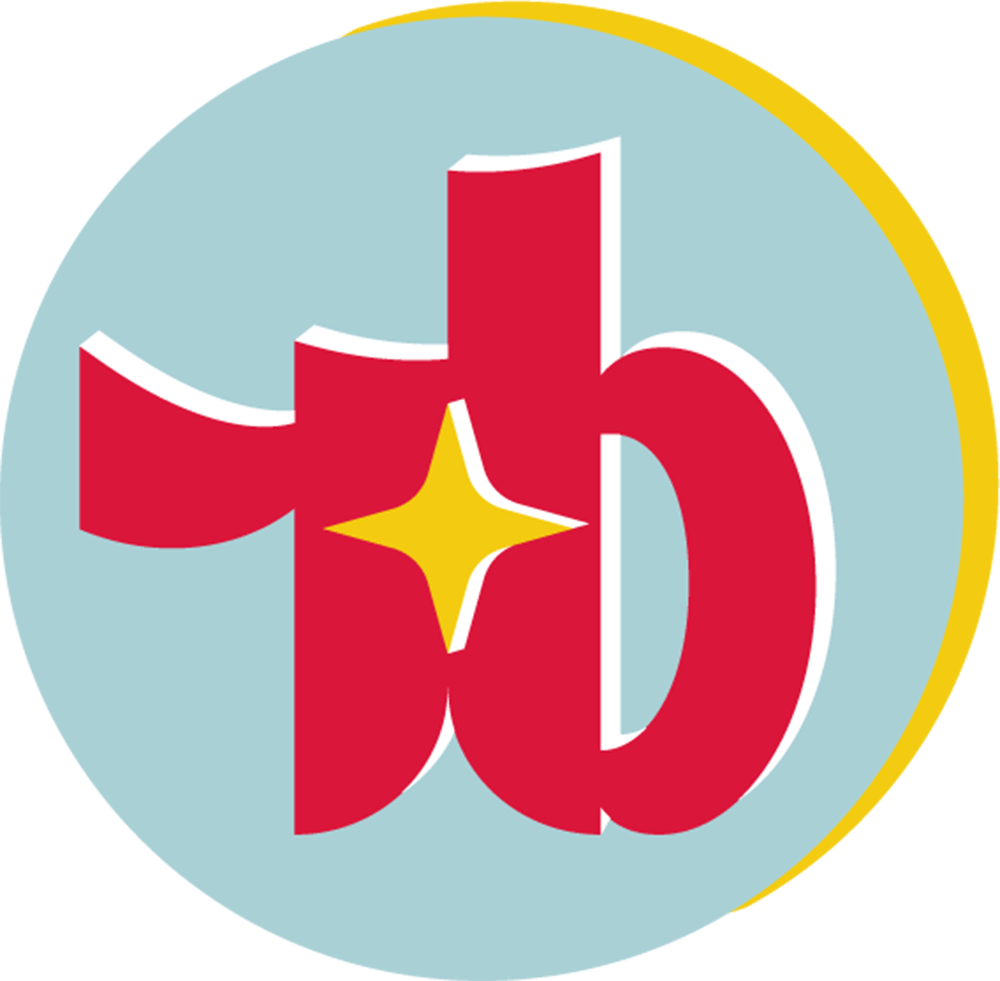
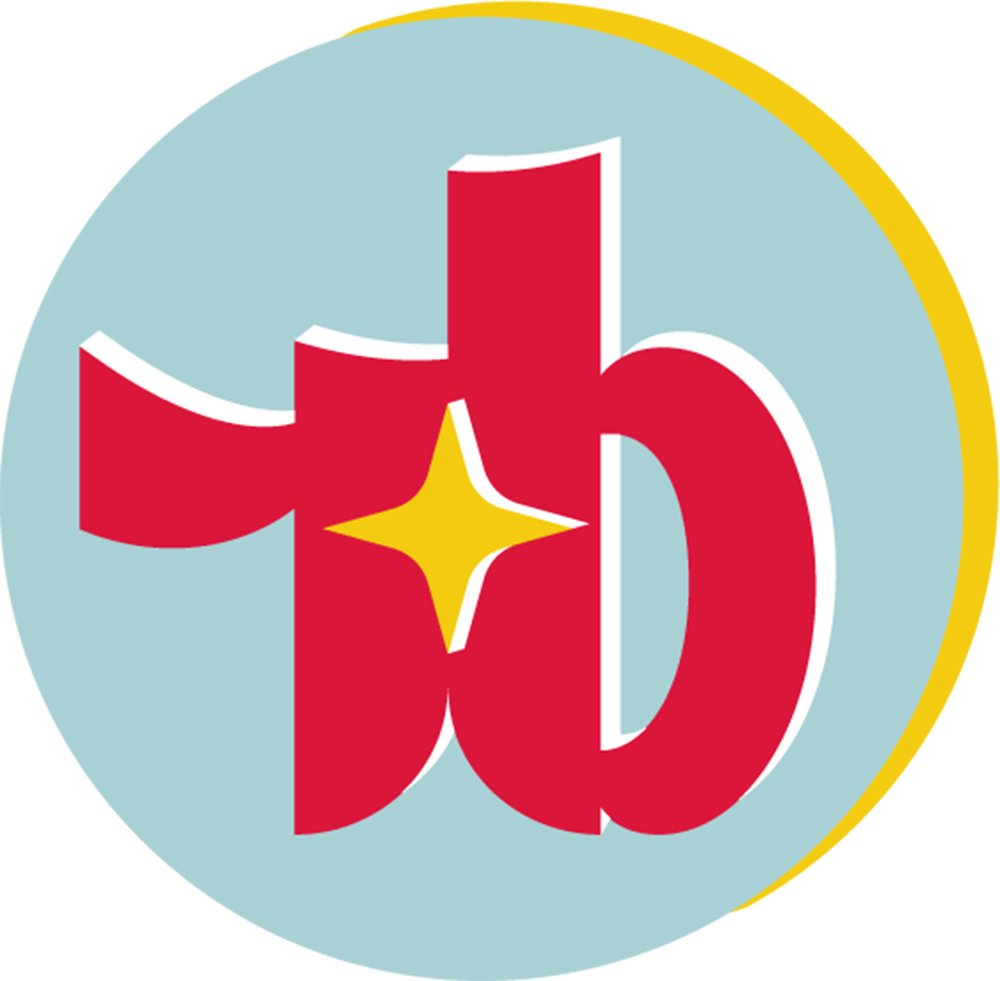



Da un’esperienza professionale,avuta con il regista PUPI AVATI, come figurante nel film il CUORE GRANDE delle RAGAZZE, ho avuto l’occasione di lavorare con il regista GALIANONE DANIELE, in qualità di ATTORE IMPROVVISATO nei suoi cortometraggi. Ringrazio gentilmente i registi che mi anno dato la gioia di vivere esperienze INDIMENDICABILI.!!!!! Vi voglio tanto BENE.!!! GRAZIE. SALUTI. BRIZI FLAVIO.